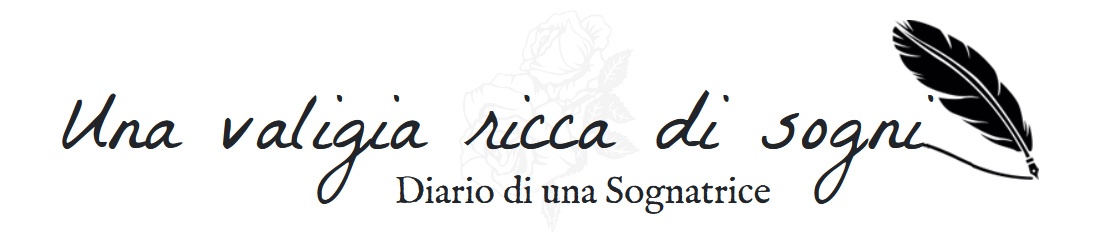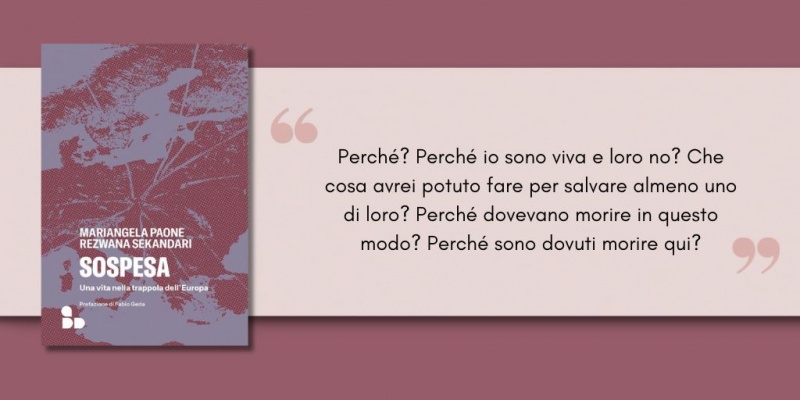Negli ultimi anni il mio sguardo sul mondo è cambiato profondamente. È come se il velo che avevo sugli occhi fosse stato sollevato, e la tragica realtà appare perfettamente nitida. Il mio pensiero sul mondo occidentale, di cui faccio parte, è molto mutato. Basti pensare alla situazione in alcune aree nel mondo, dalla Palestina, al Sudan, al Congo, senza mai dimenticare quella in Afghanistan.
Non sopporto più questo sguardo superiore che in molti adottano, né frasi come aiutateli a casa loro. Perché molto spesso casa loro è stata distrutta proprio a causa nostra. Perché non conosciamo concretamente le loro storie e il loro dolore. E allora forse dovremmo imparare a far silenzio e a provare un po' più di empatia e amore per l'altro, che non è così diverso da noi, dai nostri sogni e dalle nostre vite.
Quando ho visto questo libro, mi sono sentita subito attratta. È ormai chiaro che, accanto ai mondi di finzione, ho bisogno di avere uno sguardo costante sul presente. Perché ora che quel velo è stato sollevato, voglio continuare a conoscere la verità su molti contesti. Anche se turba e fa profondamente male.
Sospesa. Una vita nella trappola dell’Europa è un reportage di Mariangela Paone, una reporter specializzata in informazione internazionale. In queste pagine ha scelto di raccontare la storia di Rezwana Sekandari, una giovane donna afghana che ha perso tutta la sua famiglia nel terribile naufragio del 28 ottobre 2015 nei pressi dell'isola di Lesbo quando aveva solo tredici anni. Attraverso una serie di fili invisibili, persone che erano lì quel giorno o che hanno conosciuto e aiutato Rezwana, l'autrice non si limita a narrare la sua vita precedente e attuale e la terribile esperienza, ma invita anche a riflettere sul limbo emotivo di coloro che non possono neanche piangere sulla tomba dei familiari dispersi in mare; e sul limbo burocratico causato da assurde leggi sul diritto d'asilo in Europa.
Un libro importante, bellissimo e fondamentale, soprattutto oggi che il mondo sta scivolando sempre più in un baratro senza fine.
Perché? Perché io sono viva e loro no? Che cosa avrei potuto per salvare almeno uno di loro? Perché dovevano morire in questo modo? Perché sono dovuti morire qui?

Credo che l'immagine di quel bambino di soli tre anni riverso a pancia in giù sulla spiaggia sia rimasta indelebile in molti di noi. Si chiamava Alan Kurdi, un piccolo di etnia curda, proveniente dalla Siria. Terra da cui la sua famiglia era scappata per sfuggire dal terrore dell'ISIS. Alan è diventato il simbolo della crisi europea dei migranti, annegato insieme alla madre e il fratello, nel tentativo di attraversare il Mare Egeo.
Era settembre 2015.
Poco più di un mese dopo, il 28 ottobre, un altro naufragio coinvolse una barca di legno con più di 300 persone a bordo, a poca distanza dell'isola di Lesbo. Ci furono 43 morti. Tra loro, anche la famiglia di Rezwana. Suo padre Naseer, sua madre Fatima di 37 anni, sua sorella Negin, di 11 anni, suo fratello Hadith di 5 anni e la piccola Mehrumah, di soli 14 mesi. Solo lei è riuscita a salvarsi, orfana alle porte dell'Europa.
Con la cacciata dei Talebani, la vita a Kabul era diventata più serena. Suo padre Naseer era un cameramen della 1TV, una emittente televisiva privata, nei cui uffici anche Rezwana aveva trovato una seconda casa. Lì andava a fare la doppiatrice per voci di bambini. Rezwana era molto brava a scuola, otteneva i voti più alti. Inoltre aveva un rapporto speciale con sua sorella Nagin, la sua pietra preziosa, e profonde amicizie con le sue compagne di scuola, Tamana, Farzana e Arzo. Insomma, viveva una vita simile alla nostra. La sua famiglia, poi, non aveva problemi tra figli maschi o femmine; c'era amore e molta libertà. Con il ritorno dei Talebani, però, Kabul non era più un posto sicuro. Suo padre venne preso di mira perché giornalista, e nacque in lui l'idea di andar via. Magari in Svezia, dove vivevano alcuni parenti. Mettendo da parte una gran quantità di denaro, sperava di consentire alla sua famiglia di intraprendere un viaggio sicuro. Ma le cose, ben presto, si rivelarono molto diverse da ciò che aveva sperato.
Iniziò un viaggio non privo di difficoltà, che li portò a Teheran con un aereo, e poi attraverso l'Iran, con vari minibus o in dei tratti anche a piedi, fino alla Turchia. Lì, però, furono spesso respinti dai soldati e costretti a tornare indietro. Suo padre aveva pagato per la traversata verso la Grecia su una barca più grande, ma si ritrovarono a bordo di una di legno molto vecchio. E lì, tra quelle fredde acque, persero la vita. Ad eccezione di Rezwana, salvata dai volontari delle ONG norvegese e spagnola (la Open Arms).
Attraverso questo diario collettivo, leggiamo diverse voci. Fili invisibili che permettono di far luce non solo sulla vita di Rezwana che Mariangela Paone prende molto a cuore - e non solo lei! -, ma anche su quello che è accaduto quel terribile giorno. Emergono delle ambiguità. Nessuna delle navi delle autorità europee era preparata, infatti, per affrontare con efficacia un'operazione di salvataggio. Una delle navi di Frontex (ma del resto ho scoperto con chi collabora, quindi non sono per nulla stupita), non fa nulla per molto tempo. Addirittura c'è un elicottero militare che sembra riprendere la tragedia e intralciare i soccorsi, abbassandosi troppo vicino ai disperati. Solo l'intervento dei volontari delle ong con le loro moto d'acqua e di altri abitanti greci, riesce a consentire di salvare più vite possibili.
Erano perfettamente equipaggiati per mantenere a distanza le persone, non per salvarle.
Rezwana è salva, ma... accanto al dolore immenso per la perdita subita, inizia per lei una situazione ancora più complicata. È sola in un paese che non conosce. Passa attraverso tre famiglie di accoglienza ad Atene e solo nell'ultima trova un po' di conforto e tranquillità, legandosi molto alla sua mamma greca, Katia. Tuttavia il suo sogno è poter realizzare il desiderio di suo padre: raggiungere la Svezia, dove vive una delle sue prozie. Nonostante alcuni ostacoli burocratici, riesce ad arrivarci nel 2018. Per lei è un nuovo inizio. Qui ritrova il sorriso e la voglia di vivere. Studia e impara ben presto la lingua, instaura rapporti e si sente a casa. Eppure, quando compie 18 anni, è costretta a tornare in Grecia. Siamo di fronte a un sistema di accoglienza europeo mosso da una burocrazia ottusa che vede le persone come numeri od oggetti, ignorando desideri, sogni, dolore. Tornare in Grecia, per lei, significa rientrare nella terra in cui ha perso la sua famiglia, in cui riaffiora con forza tutto il suo dolore.
Il diritto di asilo in Europa è regolato dal Sistema di Dublino, che regola le politiche di accoglienza dei rifugiati nell'Unione Europea. Questo sistema prevede che ogni richiesta di asilo possa essere esaminata da un solo Stato Membro, gestita dal primo paese di arrivo: i rifugiati sono quindi legati a una destinazione obbligatoria e non possono muoversi a loro piacimento, nemmeno per raggiungere altri membri delle proprie famiglie.
È un volume che, quindi, vuole mettere in luce questa assurdità, ma anche non gettare nell'oblio una storia simile, che è un riflesso di tante altre vite che ancora oggi subiscono le stesse perdite e orrori che ha provato Rezwana sulla propria pelle - se non peggio! - .
Questa storia aperta, come una ferita che non guarisce, come una speranza che non si spegne - così come la definisce l'autrice - ci porta anche a comprendere quale sia il percorso per affrontare la perdita e tutto il dolore che essa comporta. Rezwana, infatti, fa una richiesta: tentare di scoprire la sorte dei suoi genitori, delle sorelle, del fratellino, perché se già l'averli persi per sempre è un dolore molto grande da affrontare, il pensiero che non esista neanche una tomba sui cui piangerli è ancora più grave. Si parla di perdita ambigua, quel limbo emotivo in cui rimangono sospesi i famigliari dei dispersi, un dolore mescolato alla speranza, che diventa poi disperazione quando non si hanno risposte.
Per la famiglia è una ferita che non si rimargina mai, ma è ancora peggio se non c'è un corpo, non c'è una tomba, né un luogo verso cui indirizzare il dolore di quella catastrofe immensa. Per questo continuiamo ad andare avanti: per dare a quelle famiglie la possibilità di avere risposte.
Entrano in gioco una serie di fili invisibili: persone che hanno conosciuto e aiutato la ragazza; come Charly, la prima a occuparsi di lei, volontaria dell'ONG Norvegese A drop in the ocean; o Penny, della METAdrasi o anche testimoni diretti del naufragio, altri giornalisti, volontari, fotoreporter e altri ancora. Queste persone con le loro voci e le loro azioni, creano una sorta di catena che porta a scoprire almeno la sorte della sua mamma, della sorella e del fratello. Mentre restano incerte quelle di suo padre e della sorellina più piccina. Ma ci sono ancora Minos, Natassa, Mohammadi, Mikel, Nahid, solo per citare alcuni nomi. Persone che fanno pensare che ci sono ancora tante splendide gocce che unite possono fare un mare che aiuta e che non distrugge.
Nel cimitero di Kato Tritos si apre e si chiude questo volume: Rezwana si china a sfiorare le tombe dei suoi cari e piange chiedendosi perché solo lei abbia avuto la fortuna di restare in vita. Questa piccola grande donna che, sopravvissuta a un dolore indescrivibile, irradia una forza straordinaria.
Per me è stato davvero importante leggere questo libro, perché si uniscono altri tasselli che spingono ad aprire gli occhi su molti aspetti della realtà. Perché anche in questo caso si tende quasi a deumanizzare i rifugiati, a disprezzarli perché arrivano in massa nei nostri paesi, senza neanche fermarsi a riflettere sui motivi che li spingono a tali viaggi, sulle condizioni che li hanno portati lì, sul dolore provato, sulle perdite subite. Accanto a esseri ignobili, come organi burocratici che non hanno alcun rispetto per i sentimenti umani, o mezzi di soccorso inadeguati che aiutano chi va a sfruttare questa povera gente anziché dare una mano ai disperati, esistono però persone che cercano di tenderla quella mano. Persone che hanno un cuore, che non vedono differenze di pelle. Perché possiamo anche vivere distanti e avere culture diverse, ma siamo tutti umani. Tutti appartenenti a questa Terra, sempre più triste, sempre più in pericolo.
Sin dalle prime pagine avrei voluto abbracciare Rezwana. Importanti, poi, sono le sue parole sull'Ucraina e la guerra, che secondo me racchiudono un po' tutto il pensiero che ho cercato di buttare giù sulle differenze evidenti che esistono nel mondo.
Mi sento vicina al dolore degli ucraini. Sono molto triste per quel che sta succedendo. Ma ho anche pensato che adesso hanno aperto le frontiere. Quando arrivarono i talebani, i Paesi vicini le chiusero. Il colore della pelle, dei capelli, degli occhi, contano. Non tutti vengono trattati allo stesso modo.
Non è tristemente vero questo pensiero? Lo provo anche io, che invece ho la fortuna di appartenere a quella parte di mondo - per ora - più tranquilla. È sempre stato così, ora ancora di più.
Se penso alla sua terra, a quell'Afghanistan dove per un attimo avevano sperato di avere una vita migliore, per poi essere lasciati di nuovo soli, a perdersi in un nuovo buio. Se penso a quelle donne e bambine costrette a restare chiuse in casa, nascoste da un burqa, impedendo loro di studiare, cantare, o anche solo parlare... mi sale una grande rabbia, unita a tristezza. Se non si fosse arrivati di nuovo a questo punto, Rezwana e la sua famiglia sarebbero di nuovo lì, nella loro amata terra, svolgendo lavori adorati e realizzando i propri sogni. E invece... è successo tutto questo. E noi che ci definiamo tanto democratici e civili, li respingiamo, li odiamo, li disprezziamo, applicando anche leggi assurde che non hanno alcun rispetto per la loro anima, i loro sentimenti, il loro dolore.
Ecco perché questo libro, secondo me, è di particolare importanza. E vi consiglio di cuore di recuperarlo.
Non lasciamo che queste storie cadano nell'oblio, ma facciamole risuonare, affinché possano ispirare cambiamenti o una possibile maggior empatia.
La storia di Rezwana non è solo un racconto di perdita, ma riflette anche la forza di una ragazzina, ormai donna, che ha cercato di lottare e accettare il suo dolore, trovando anche una strada e una nuova vita, nonostante tutti gli ostacoli e i limiti di una burocrazia priva di umanità.
È stato pubblicato da ADD editore, e ringrazio infinitamente Silvia per la copia digitale.Dal 2014 nel Mediterraneo sono più di 26.000 le persone scomparse mentre tentavano di raggiungere l'Europa.
Lo trovate qui.